Come si faceva il pane in casa nei tempi antichi a Solicchiata
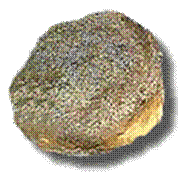
“Dacci, oggi, il nostro pane!”
Il pane. Un bene di tutti. L’alimento primario comune, oggi facilmente reperibile, che spesso ci viene consegnato addirittura in casa dal sollecito garzone del fornaio. E’ il caso, quindi, in questo contesto, di richiamare alla memoria la sua storia, di considerare quale e quando lavoro, amore e perizia comportava la sua preparazione? Dopotutto, si sa, lo sanno tutti, il pane si fa con la farina e la farina si fa col grano. Però, a me piace ricordare ai giovani come si faceva il pane, una volta , nelle nostre case. Mi piace ricordare la bontà di quel pane: del buon pane casereccio siciliano, fatto con la farina, certo, ma soprattutto con la perizia, lo zelo e l’amore di ogni mamma. Era una preparazione laboriosa, un procedimento lungo del quale la panificazione vera e propria era soltanto la fase conclusiva. La prima fase della massaia era quella di prelevare la giusta quantità di farina corrispondente al numero dei pani che poteva contenere il forno di casa. Preliminarmente, però, essa poneva sul fuoco una grande pentola d’acqua a scaldare e cominciava a stacciare la farina, con il crivu dà farina (lo staccio della farina) era stretto: era calibrato in modo da lasciar passare la farina e trattenere la crusca. Nelle mani della massaia, lo staccio oscillava veloce, danzava, prillava, e via via separava la bianca farina che cadeva dentro la maidda dalla crusca riservata alle bestie della stalla (il mulo,il maiale o le galline). Ultimata la stacciatura, la massaia conformava la farina a conca, dentro la maidda; versava nella conca una giusta quantità d’acqua calda e vi scioglieva u criscenti o rinnuvu (il lievito) appositamente conservato nel solito vaso di coccio smaltato (a criscintera). Era usanza, fra vicini di casa o parenti, dare e chiedere in prestito il lievito. La giusta dose di questo generalmente era sempre la stessa: corrispondeva alla quantità di pasta necessaria per una pagnotta da un chilo. Quindi, all’atto della formazione dei pani, una quantità di pasta equivalente ad una pagnotta veniva riposta nell’apposito vaso di coccio perché fermentasse e diventasse essa stessa lievito. Completata la soluzione del lievito, si cominciava a impastare la farina, iniziando dal bordo interno della conca. L’impastatura richiedeva destrezza e lunga esperienza: via via, per formare l’impasto, vi si aggiungevano in giusta dose altra acqua calda ed il sale necessario; e, pigiando coi pugni, la massaia spianava la pasta; poi la girava, la piegava, la rivoltava, la spianava ancora, ripetutamente, fino a quando l’impasto diventava perfettamente amalgamato, elastico, liscio; senza mai fermarsi, per non correre il rischio di raffreddare la pasta, compromettendone la giusta lievitazione successiva. Completate queste operazioni, la massaia copriva i pani sulla lettiera con una pesante tovaglia e poi vi stendeva sopra una coperta perché ne fosse mantenuta la giusta temperatura per la lievitazione. Il riconoscimento della giusta lievitazione del pane e del giusto riscaldamento del forno implicavano esperienza e vigilanza. Il forno doveva essere acceso per tempo, bruciando legna o gusci di mandorle. La legna posta ad ardere in esso doveva essere opportunamente spostata, all’interno, perché il forno venisse scaldato uniformemente e alla giusta temperatura. Quando il forno era caldo al punto giusto, allora non c’erano i termometri per misurare quelle temperature, e si regolava in base al colore che avevano assunto i mattoni che costituivano la bocca del forno. La massaia tirava fuori, con un rastrello ed una paletta di ferro, tutto il fuoco che, messo in un grande recipiente di ferro con relativo coperchio “u stutafocu”, diventava carbonella che poi si usava nella “conca”, cioè il braciere che serviva per riscaldarsi durante l’inverno. Dopo sempre con grande sveltezza, con una scopa inzuppata di acqua, il piano di cottura veniva pulito, in modo che nel pane si attaccassero dei pezzetti di carbone. A questo punto il forno era pronto per ricevere i pani già lievitati: la massaia li trasferiva ad uno ad uno sulla lunga pala di legno e, da questa, nel forno, disponendoli in perfetto ordine per la migliore utilizzazione dello spazio interno. Dopo chiudeva la bocca del forno con il portello in lamiera in modo che il calore non si disperdesse. La lunga e faticosa operazione era finita e a questo punto la massaia, asciugandosi il sudore causato dalla fatica e dal calore, si sedeva, (finalmente!), attendendo la cottura del pane. Anche il tempo della cottura era misurato con l’esperienza e guardando di tanto in tanto, con rapida apertura dello sportello. Nella prima fase della cottura i pani prendevano la giusta colorazione e perciò si diceva: “cci calau a rrosa”, (intendendo con ciò che il pane aveva assunto il giusto colore rosato). Ultimata la cottura, i pani venivano estratti dal forno, accostati l’un l’altro in un unico raggruppamento e coperti con una vecchia coperta perché conservassero più a lungo il colore e acquistassero la giusta morbidezza. Quando veniva uscito dal forno il profumo del pane si spandeva per tutta la casa e si sentiva anche fuori per lunga distanza. Durava in genere anche otto giorni, proprio perché era a lievitazione naturale; mentre oggi che si usa, anche per i tipi di pane più raffinati e sofisticati, il lievito di birra, il pane della mattina può risultare immangiabile la sera stessa, immaginiamo il giorno dopo. Ora si usa metterlo nel freezer ed è mangiabile appena scongelato e riscaldato, ma subito dopo si sfalda e si pietrifica di nuovo. Una volta il pane caldo e i maccheroni erano un lusso, un privilegio, un dispendio eccessivo, tale da ridurre in povertà persino il barone. Si, la vita di un tempo era fatta di piccole cose! Piccole cose che, però, per la gente semplice erano grandi. Piccole cose che accendevano la gioia e l’armonia nelle case. Chi non l’ha provato non può apprezzare i gesti precisi di quelle mani generose e gli occhi gioiosi di grandi e piccini, quando il pane appena sfornato veniva aperto e spianato, percorso dal filo abbondante di olio dorato, cosparso di preziosi frammenti di acciughe, spruzzato di sale e poi ricomposto e tagliato in spicchi abbondanti e tosto addentato da bocche e boccucce vogliose? Chi non l’ha provato non può giudicare la bontà del buon pane di casa siciliano, specialmente del pane di un tempo, del pane dei centri agricoli dell’entroterra siciliano. Oggi è difficile trovare il buon pane di casa: quel pane all’antica che aveva il colore dell’oro e il profumo della terra e del sole.
Gaetano Bonaventura